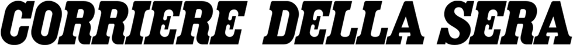Il ritorno di Hermia e altre storie
di Franco Cambi - Lunedì 04 Settembre 2017 ore 11:59

La storia di Hermia e del suo vino comincia anche prima delle scoperte archeologiche fatte nella rada di Portoferraio a partire dal 2012.
Nel 2011 un vitivinicoltore elbano curioso, motivato e innovativo, Antonio Arrighi di Porto Azzurro, decideva di provare a fare un vino rosso di corpo affinandolo in contenitori di terracotta invece che in barrique di legno. La terracotta è più neutra del legno della botte, che qualche sentore al vino lo deve pur cedere, per quanto gradevole possa essere. Inoltre, il contenitore in terracotta può sostenere molte più vinificazioni rispetto al tonneau o botte, che, dopo pochi affinamenti, ha spiegato più volte Antonio, deve essere sostituito. Il risparmio è, oltre che finanziario, anche ambientale (si tagliano meno alberi). Antonio ha chiamato questo vino Tresse dalle iniziali degli uvaggi impiegati: Sirah, Sagrantino, Sangiovese (quello che le mie nonne elbane chiamavano, chissà perché, Sangioveto).
I Romani conoscevano da due a quattro fasi di vinificazione:
- Fermentazione iniziale (più violenta) in apposite vasche costruite in cementizio e impermeabilizzate all’interno con apposita malta idraulica. Queste vasche erano chiamate in latino “lacus vinarius” e il fatto che si ricorresse all’immagine del lago per rappresentarle la dice lunga sulle dimensioni che potevano avere: anche 9,502,50, con una profondità di un metro, con una capacità che poteva arrivare a 20.000 litri.
- Fermentazione matura, in grandi vasi di terracotta (i famosi dolia, normalmente defossa ovvero interrati fino alla bocca per guadagnare in solidità) con una capacità che poteva andare dai 1000 ai 1500 litri.
- Affinamento in apposite cantine dette cellae vinariae, ancora in dolia.
- Affinamento in anfore di 26-30 litri di capacità, in cui il vino poteva, se tutto andava bene, anche invecchiare.
Ma torniamo al nostro Hermia. I bolli (o marchi di fabbrica) che questo personaggio fece imprimere sull’argilla fresca dei dolia ritrovati a San Giovanni, sono al tempo stesso indicatori dell’area di produzione di questi grandi vasi (probabilmente Minturno: anche le analisi della terracotta dei doli rimandano a quella zona) e marchio di garanzia del prodotto in essi contenuto. Hermia fu uno schiavo-manager ovvero uno schiavo particolarmente intelligente, competente e intraprendente, a cui il padrone, nella fattispecie un Marco Valerio, affidò una somma di denaro, un peculio, da investire e da far fruttare. In ragione del più o meno elevato successo imprenditoriale raggiunto, il padrone (o dominus) poteva anche decidere di affrancare lo schiavo, di farne prima un liberto, poi un uomo libero a tutti gli effetti. Nel caso di Hermia, non possiamo sapere come andò a finire. Quel che è certo è che doveva avere grande esperienza di agronomo e di cantiniere, come dimostra l’archeologia e che attorno al 100 a.C. gestì l’azienda agraria dei Valerii nella rada di Portoferraio.
Un’altra cosa che probabilmente non sapremo mai, salvo clamorose sorprese da parte del nostro amico Claudio Milanese (è lui che analizza in laboratorio i resti organici restituiti dagli scavi di San Giovanni) è il tipo di vino, e il sapore, del vino fermentato nei dolia. E’ possibile che si producesse un vino bianco di un certo corpo e anche di una certa gradazione alcolica ma questa è proprio una fantasia.
Questa estate, nella cantina di Antonio Arrighi è nato un vino bianco affinato in terracotta: si chiama “Hermia” e riproduce sull’etichetta il brand, sintetico ed efficace, che lo schiavo manager dette al suo vino 2100 anni fa.
Un brand di grande prestigio e di sicuro successo.
Franco Cambi