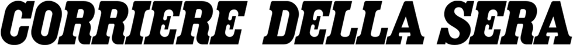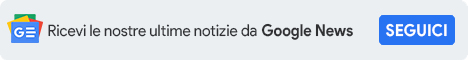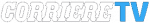
Zermatt: la valanga è spettacolare, l'enorme massa di neve arriva fno al treno. Paura a bordo ma nessun ferito

Attualità Domenica 05 Ottobre 2025 ore 06:00
Giurisdizione penale nell’antico Stato di Piombino

Su #tuttoPIOMBINO la tesi di laurea di Umberto Canovaro sul diritto penale nei secoli XV - XVIII
PIOMBINO — Ritrovare per caso la tesi di laurea (anno accademico 1979/80) di Umberto Canovaro edita da Bandecchi e Vivaldi nel febbraio del 1999, mi regala una lettura storica interessante sulle fonti del diritto nei secoli XV - XVIII nello Stato di Piombino.
Gli Statuti indicano un passaggio netto e preciso da un Medio Evo - basato sul rapporto vassallo-feudatario - a un periodo umanistico-rinascimentale che vede il bisogno di normative certe da applicare per risolvere le situazioni controverse. A Piombino lo Statuto era la prima fonte del diritto, si ricorreva al diritto comune solo in assenza di specifica disposizione statutaria, mentre alle consuetudini locali non veniva dato alcun peso giuridico. Lo Statuto a Piombino è stato un vero e proprio regolamento locale - con forza di legge certa - fino al congresso di Vienna, data in cui si assiste al crepuscolo dell’autonomia piombinese. Gli Statuti di Piombino sono difficilmente databili, forse risalgono alla fine del secolo XIII o all’inizio del secolo XIV, di sicuro prima c’è sempre stato il “Brevis Pisani Communis” (detto “il Breve”), dettato per stabilire il comportamento del Capitano e degli altri ufficiali di stanza a Piombino. Gli Statuti, invece, servono a disciplinare le relazioni giuridiche inerenti il Comune e sono suddivisi in tre libri: il primo fa riferimento al Constitutum legis, il secondo al Constitutum usum e il terzo torna ancora al Breve Pisano. Si conoscono cinque edizioni degli Statuti e nel corso di tre secoli hanno subito modifiche, sempre nella grande continuità del sistema normativo, pur caratterizzato da tre diverse dinastie: Appiani, Ludovisi e Boncompagni-Ludovisi. Le fonti del diritto a Piombino sono state per molti anni sia il Breve (per la parte relativa al diritto pubblico e al comportamento del cittadino), sia lo Statuto (per i rapporti tra privati, di natura civile e criminale). La pubblica funzione di giudicare era affidata a un Vicario o Podestà, nominato dal Principe, scelto tra persone non abitanti a Piombino, dottore in diritto civile e canonico, oltre ad avere alle spalle un’esperienza come amministratore della giustizia in altro luogo. Il Vicario era accompagnato da un Notaio pubblico (pure lui non piombinese), era tenuto al giuramento di fedeltà ed aveva un mandato che durava un anno, salvo rinnovo. Il Vicario aveva funzioni molto ampie, interveniva anche nei vari Consigli di Comunità, aveva un buon trattamento retributivo e a fine mandato due sindaci facevano un lavoro di revisione sul suo operato. Il Vicario bandiva le udienze, conduceva l’azione penale e civile, faceva in modo che in caso di denunce venisse dato un seguito, ascoltava i testimoni, conduceva il processo e proclamava la sentenza finale (appellabile). Il Notaio non era un semplice scrivano, ma le sue funzioni erano tali da farne una figura attiva del processo e di tutto il sistema giuridico, per esempio stendeva il verbale dell’interrogatorio dei testimoni e controllava che le sentenze venissero rispettate. Un processo iniziava con il suono della campana del Palazzo - che rintoccava a ogni udienza - e la stessa campana ne indicava il termine, subito dopo che il Vicario aveva pronunciato la sentenza a voce alta. Il processo cominciava con una citazione recapitata nelle mani del reo, poteva avvenire anche in contumacia (in quel caso vigeva la presunzione di colpevolezza), aveva determinate regole di prescrizione, il suo fulcro risiedeva nell’audizione dei testimoni, infine la confessione era sempre ammessa (prima della sentenza) e valeva uno sconto di pena. Il secondo grado processuale non era una certezza a Piombino. Pietro Calefati lo riteneva ammissibile solo nel caso di decisioni lasciate all’arbitrio del giudice, mentre a suo dire sarebbero state inappellabili le sentenze basate su una norma dello Statuto. Un altro giurista come il Gambiglioni, invece, era di opinione del tutto opposta e riteneva errata la prassi locale di non concedere il secondo grado di giudizio al condannato.
In breve vediamo i delitti e le pene contenuti nello Statuto Piombinese. I reati si dividevano in ecclesiastici, secolari e comuni, ma una divisione ancora più importante era quella tra privati e pubblici. I reati pubblici erano atti criminosi che ledevano il pubblico interesse; potevano essere tutti i comportamenti che andavano contro la persona del Principe, la religione e le istituzioni pubbliche, ma era un reato pubblico anche spedire lettere a un nemico dello Stato, persino cedere un fortilizio o un terreno a un nemico pubblico. Tipica la divisione tutta medievale e rinascimentale tra delitti lievi (senza dolo), gravi (con dolo) ed enormi (gravissimi). La definizione di reato enorme a Piombino non era lasciata al libero arbitrio del giudice ma lo Statuto indicava un preciso elenco: omicidio, furto, incesto, stupro, cospirazione, sodomia, aggressione per strada, rapina, incendio, veneficio, arte magica, coniazione di monete false, falsificazione di scritture o documenti, falsa testimonianza, falsa sentenza, furto di cose sacre, rottura della pace o della tregua, amputazione di membra. E pi c’erano i crimini che comportavano infamia, quindi subire certe debilitazioni morali e personali che riducevano lo stato di cittadino, come non poter testimoniare o l’essere sottoposto a tortura in presenza di labili indizi. Per ricadere sotto condizione di infamia a Piombino non serviva un delitto enorme (vedi elenco), ma bastava una falsa testimonianza, una falsificazione di documento, un delitto che arrecava danno allo Stato. Ultima distinzione che faceva lo Statuto era tra delitti commessi nei confronti degli abitanti di Piombino e delitti commessi verso i “forensi”. Nel secondo caso si procedeva e si condannava secondo il diritto vigente nella patria dell’offeso, ma solo se il delitto era stato commesso in terra straniera e se la pena prevista era minore rispetto agli Statuti Piombinesi. Inoltre le pene previste erano corporali, pecuniarie e capitali, graduate secondo la gravità del crimine e secondo la persona che aveva commesso il fatto. Non era vero che la pena fosse sempre la stessa, in ogni parte della penisola, ma cambiava secondo la concezione del diritto in un determinato luogo. Nei comuni retti da una democrazia uccidere un popolano era reato più grave rispetto ai comuni autocrati, come Piombino, retto da Principi, sia che fossero Appiani o Boncompagni-Ludovisi. Un danno arrecato agli interessi agricoli era più grave nei comuni rurali, turbare la pace pubblica era più grave dove vivevano molti forestieri, infine c’erano luoghi dove la sanzione preferita era il capitale mobile, altri la proprietà fondiaria. A Piombino, Stato autocrate, erano frequenti le pene corporali, l’esilio, la condanna alle triremi pontificie, tra l’altro pena non prevista dallo Statuto, ma derivata dal diritto comune. A Piombino per un reato commesso di notte si raddoppiava la pena, così come era più grave un crimine compiuto nella zona diPorta a Terra, nei pressi dell’abitazione del Signore, accanto a una Chiesa, un fortilizio, un Tribunale o vicino al Consiglio Comunale. Pena doppia se il delitto veniva commesso a Natale, per Pasqua, per Sant’Anastasia(santa patrona cittadina), il Venerdì o il Sabato Santo.
Altre curiosità dello Statuto per la parte criminale, desunte dalla tesi di laurea di Umberto Canovaro, il fatto che si punissero i bestemmiatori (pena pecuniaria da dieci lire fino a cento), ma si punivano in modo diverso secondo la gravità della bestemmia e la condizione dell’imputato. La falsità e la non veritiera deposizione testimoniale comportava pena pecuniaria e fustigazione, con aggiunta della bolla d’infamia nei casi gravi. Pene dure anche per chi vendeva merci contraffatte e coniava monete false, oltre al risarcimento del danno nei confronti del leso. Pena molto severa riservata a chi offendeva con parole o atti gli Anziani o un ufficiale del Principato di Piombino; poteva essere una sostanziosa pena pecuniaria accompagnata da una pena corporale. I reati contro la persona erano repressi in modo molto duro, si aveva particolare attenzione ai reati commessi da donne, perché era giudicata riprovevole una rissa femminile per le strade cittadine, così come si punivano con fermezza le ingiurie pronunciate da una donna. Particolare attenzione alle percosse, punite con pene pecuniarie più gravi secondo il tipo di conseguenza, fino alla legge del taglione se il reo non adempiva al pagamento. Esempio: amputazione per amputazione, dente per dente, occhio per occhio. Lo Statuto prevedeva anche tutti i reati a sfondo sessuale - intesi contro la persona, non ancora contro la famiglia -, si andava dal rapimento (ratto) all’atto sessuale non consenziente(stupro), ma in caso di donna sposata veniva punito anche se consenziente. La sodomia era reato punito in modo molto duro, perché lo Statuto prevedeva il rogo per incutere timore e impedire il cosiddetto “proliferarsi del vizio”. Se il sodomita era minore di anni 18, la pena comminata era la pubblica fustigazione con il conseguente marchio d’infamia. L’omicidio premeditato veniva punito con la pena di morte, mediante “amputatione capitis”, il taglio della testa. Per l’omicidio colposo la sanzione era soltanto pecuniaria, mentre per le situazioni non colpose (forza maggiore, caso fortuito) e per legittima difesa scattava la non punibilità. Molto dure anche le pene previste per i reati contro il patrimonio. Furto e rapina prevedevano l’impiccagione e la restituzione del maltolto; se il ladro non era notorio ci si limitava alla fustigazione, se era la seconda volta che veniva condannato gli si amputava l’orecchio destro e gli si sfregiava il volto con un ferro caldo. L’incendio doloso veniva punito con forza, fino al comminarsi della pena di morte, nei casi più gravi, oltre al risarcimento del danno procurato. Per concludere dobbiamo dire - con Canovaro - che lo Statuto Piombinese era un corpus normativo abbastanza evoluto, in perfetta sintonia con il sistema del diritto medievale.
“La giurisdizione penale nell’antico Stato di Piombino” è il secondo lavoro saggistico di Umberto Canovaro - uomo politico di grande livello e ottimo storico recentemente scomparso -, merita una rilettura e un approfondimento perché dice cose originali e poco conosciute che ho cercato di sintetizzare e divulgare per rendere un testo scientifico abbastanza complesso di pubblica comprensione.
Gordiano Lupi
© Riproduzione riservata
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI