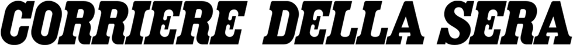Confessioni
di Marco Celati - Domenica 08 Gennaio 2017 ore 08:00

Mi sono sempre chiesto e mi chiedo ancora perché scrivo. Cosa mi spinge a farlo. Perché ho preso un impegno con la redazione? Certo, ma non solo. Per vanità intellettuale e narcisismo? Anche, ma non soltanto per questo. Così, tanto per fare, magari per una semplice coazione a ripetere, una volta iniziato, e solo per riempire una pagina bianca e vuota, come è spesso la vita? Può anche darsi, ma non è questo. So bene che scrivere di scrivere e dubbi relativi è cosa già letta e sentita. Oltretutto messa in atto da penne e menti migliori. So altresì che la risposta a queste domande non interessa a nessuno, all'infuori di me e forse poco anche a me. Però una risposta si deve o comunque devo darmela. E la prima risposta è che, in realtà, scrivo perché mi piace. E non è nemmeno che mi venga facile farlo. Non ho il dono della scrittura che nasce subito bella, non ho il tratto immediato. Devo cancellare, aggiungere e sottrarre. Mi succede anche quando disegno o dipingo, le rare volte che lo faccio, ormai. Cancello, ritocco, sfumo, riempio, svuoto: così quando scrivo. Non ho fantasia, semmai ripeto maldestramente la realtà o ciò che credo di interpretare come realtà.
E scrivo per lasciare qualcosa di me, dopo di me, a coloro che leggono o leggeranno. Coloro che fossero interessati a capire chi sono o chi fossi e magari lo capissero anche meglio di quanto sia stato capace io di capirlo di me stesso. Sono arrivato ad una fase della vita in cui penso che, nonostante creda nel progresso delle cose e nel loro futuro, è impossibile non guardare al passato e non rendere conto. So che morirò, ne ho preso più coscienza e paura, terminerà per sempre il mio contatto con il mondo, con la terra, la relazione con i miei cari e così occorre consuntivare più che preventivare l'esistenza. Naturalmente non sono vietati gesti apotropaici.
Scrivo perché ho vissuto una vita oggettiva e pubblica eppure anche soggettiva e sensibile. Ciò che da giovane, impetuoso e sciocco, mi sono vergognato di mostrare, ora, da vecchio, mi appare non tutto questo granché, ma almeno degno di essere manifestato. Ho sempre pensato, anche se non sempre detto, che le due cose non sono in contrasto tra loro. Anzi aiutano, o avrebbero potuto farlo, a rappresentare e cogliere una qualche complessità delle cose, dell'animo e della mente.
Qualcuno dice che la mia vena più apprezzabile sia l'ironia, altri la malinconia, la tristezza e lo spleen, la nostalgia e la "saudade". Qualcuno, forse i più saggi, dicono che se smettessi sarebbe anche meglio. E che questo egocentrismo sarebbe da curare. Sinceramente non lo so. So che scrivo e che sono. E scrivo come scrivo e sono come sono. Questo è. Oppure, alla fine, è forse più per dire di come avrei voluto essere e non sono stato. Di quanto non sono stato capace di fare per rendere migliori la vita, la società, il tempo che si vive, l'amore che si dà e si riceve. Scrivo perché desidero condividere la pazienza di addormentarmi la notte e l'odore del latte scaldato al mattino, perché mi piace cogliere la poesia delle cose. Scrivo perché sento e mi piace sentire.
C'è chi mi dice sei bravo e io mi schermisco, ma a volte mi piace sentirmelo dire, perché sono un irresistibile citrullo. Citrullo è un'offesa affettuosa che si usa in Toscana, ma viene dal Sud, deriva da "citriuolo", cetriolo oppure è un italianizzazione del francese "citrouille", zucca: fate voi. Sopratutto non sopporto gli adulatori e non sono capace di sostenere i complimenti, sono più abituato a contrastare i detrattori: deve essere un'eredità della politica.
E poi ci sono quelli più simpatici che mi dicono: va be' scrivi, ma almeno non ci rompere i coglioni, raccontaci una storia, piuttosto. Sennonché non ho storie da raccontare, le storie mi vengono per caso e l'ingegno, se così si può dire, è di quelli brevi, un po' eclettico e vagabondo: mi abbandona presto ed esige subito una fine. È più da "poeta" mancato che da prosatore riuscito. Giustifico questo con il fatto che oggi tutto mi appare breve e spezzato, atomizzata l'esperienza e ciò non incoraggia o giustifica il romanzo. Ma forse dipende solo dalla mia incapacità o svogliatezza. Ho fatto diverse cose nel corso del tempo e dell'esistenza, non di tutte sono fiero, di qualcosa provo vergogna. Orrore di sé, in giusta misura, ognuno dovrebbe averne. Propendo comunque ad assolvermi nel complesso, se non altro per carità di patria. Ma queste diverse cose tendo a non ricordarle, a non inquadrarle in un diario quotidiano o complessivo di storia e di vita. Insomma mi sembra di non aver vissuto granché, senza offesa per nessuno. È un problema mio, è solo colpa mia. Quindi penso di non avere nemmeno granché da raccontare. Ma poi qualcosa viene e riaffiorano vite, sentimenti, relazioni con il mondo e sono grato a chi mi ha accudito e amato o voluto bene. Anch'io ne ho voluto. O a chi mi ha più semplicemente rispettato o insegnato qualcosa e chissà se qualcosa anch'io ho insegnato, se qualcuno qualcosa ha imparato da me. Male ne ho fatto, purtroppo, e qualcosa del male ho ricevuto anch'io.
Scrivo dunque di niente e del niente che è. Ma in fondo è tutto qui: quel poco o quel tanto che si è, che si ha o che si è fatto. Quello che si ricorderà di noi o che noi ricordiamo. Sono storielle, minutaglia, brevi e inconcludenti racconti, si svolgono anonimi o sotto falso nome, a lato della vita vera; rimandano la soluzione del dilemma vero o presunto: o si vive o si scrive. Eppure finché hai voglia di scrivere vuol dire che hai ancora voglia di vivere. E forse solo per questo, alla fine scrivo.
Pontedera, 12 Maggio 2016
Marco Celati